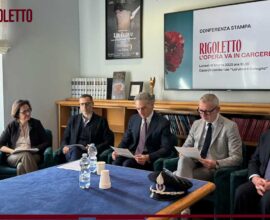Mauro Santopietro, l’intercultura comincia dall’ascolto sul palcoscenico
Tendere le mani al prossimo aprendo le porte di un teatro. È quello che fa il Laboratorio “Oltre i Banchi” con gli immigrati e gli italiani di seconda generazione. Quattro anime belle si prendono cura di questo percorso di integrazione: l’organizzatrice Grazia Sgueglia, la mediatrice culturale Cristiana Russo, la formatrice Interculturale Cinzia Sabbatini della Fondazione InterCammini e il regista Mauro Santopietro. “Il lavoro consiste nel creare uno shock culturale o comunque un imprinting culturale, facendo raccontare a queste persone la propria storia, in modo da creare dei modelli che possano dare una voce, un nome alle cose e che possano rompere un silenzio, chiedere aiuto, creare un’attenzione, una vicinanza, pensare a delle soluzioni”, afferma Mauro Santopietro, regista ed attore diplomatosi presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Romano classe 1982, lavora in diverse compagnie stabili e private, e per diverse produzioni televisive e cinematografiche. “Dovrei molto probabilmente tornare al Globe Theatre di Roma con ‘Le allegre comari di Windsor’, quindi ‘Falstaff’, e una nuova produzione con la regia di Loredana Scaramella, che sarà ‘La commedia degli errori’. Questo è ciò che farò con la compagnia del Globe. Dopodiché dovrei anche tornare a fare del teatro con la Compagnia Knuk, quindi con Alessandro Averone, Marco Quaglia, Alessia Giangiuliani, Antonio Tintis, Mimosa Campironi, Gabriele Sabatini. Dovremmo tornare in scena con il Pirandello che facemmo al Teatro Vascello qualche anno fa (‘Il Piacere dell’Onestà’, ndr). In più sto cercando di portare avanti un format di documentari”. Mauro Santopietro ha tanti progetti in corso, ma non trascura mai l’impegno con il Laboratorio “Oltre i Banchi”, l’importantissimo lavoro nel segno di un Teatro sociale vivo.
Mauro Santopietro, avevi esperienze precedenti di Teatro sociale prima del Laboratorio teatrale “Oltre i Banchi” cominciato cinque anni fa?
“Ho lavorato con gli anziani. Ho messo in scena uno spettacolo con loro, dopo un anno di laboratorio dove si è lavorato sulla memoria. Lì ho ricevuto i complimenti più belli che mi siano stati fatti perché alcuni dei figli di questi anziani mi hanno detto di aver scoperto delle cose dei genitori che non sapevano e gli anziani stessi mi hanno detto di ricordare delle cose della loro vita che avevano dimenticato. Questo lavoro sulla memoria nasceva dal fatto che nessuno chiede più agli anziani di raccontare sé stessi e la propria storia. Da questa esperienza mi è venuto in mente di partecipare insieme alla Spring, quindi con Grazia Sgueglia, al progetto che poi ha dato vita a ‘Oltre i Banchi’, dove ho conosciuto Cristiana Russo e Cinzia Sabbatini, quindi la Fondazione InterCammini, attraverso MigrArti. A questo percorso con gli immigrati, poi, ho affiancato anche altro lavoro di Teatro sociale. Questo è il secondo anno che collaboro con l’Asl Roma 1, con il Dipartimento dei Disturbi del comportamento alimentare, quindi con le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia. L’anno scorso queste ragazze sono andate in scena con uno spettacolo al Pac (Padiglione di Arte Contemporanea di Milano) di Milano grazie all’Onlus Ri-scatti e quest’anno ci sarà un altro spettacolo da fare alla fine del ciclo, cioè a dicembre. Mi muovo molto sul Teatro sociale in questi ultimi anni. Ho lavorato anche nei Centri di accoglienza, con la Caritas, sempre con gli immigrati, ragazzi che, arrivati da poco in Italia, soprattutto minori, riscontravano diverse problematiche”.
Come ti approcci a loro? Come li conduci sul palcoscenico con le loro storie?
“Il lavoro è molto lungo ed è quello che fa un operatore culturale. Fondamentalmente cerco di essere piuttosto laconico, perché il lavoro è molto complesso e fatto anche di grandi sinergie con una équipe; quindi, non si lavora mai da soli. Comunque, il lavoro consiste nel creare uno shock culturale o comunque un imprinting culturale, facendo raccontare a queste persone la propria storia, in modo da creare dei modelli che siano sempre più importanti, modelli che possano dare una voce, un nome alle cose e che possano rompere un silenzio, chiedere aiuto, creare un’attenzione, una vicinanza, pensare a delle soluzioni. Quindi, fondamentalmente è creare cultura, cioè un confronto, un ascolto di sé stessi, delle proprie storie e delle storie degli altri. Questo è fare un’operazione culturale lavorando su delle emozioni che vengono però innestate dentro un processo narrativo, che è una storia che ha un inizio, un centro e una fine, dando vita quindi ad un’esperienza viva, non un’esperienza scritta che rimane sterile, poco vissuta. Questa esperienza viva della narrazione va a supporto di un’intelligenza emotiva, di una coscienza emotiva della narrazione, per far capire che comunicare attraverso delle emozioni è molto importante e che, ahimè, è sempre meno scontato. Tutto questo lo si fa creando dei modelli in cui riconoscere un’emozione che crea un confronto, un ascolto e questo diventa fondamentale sia per chi ascolta, sia per chi in realtà va sul palcoscenico. Noi non creiamo degli attori: il laboratorio teatrale non è di natura culturale, ma è interculturale, non ha l’obiettivo di creare degli attori, ma di creare delle coscienze che sappiano interagire, che sappiano avere un’inclusione sociale all’interno del vissuto territoriale in cui si agisce, quindi degli attori sociali che sappiano interagire nel territorio. In fondo, inclusione sociale vuol dire proprio avere il diritto alla felicità, cioè far sentire loro possibilmente felici quanto tutti gli altri”.
Come lavori con loro? Parti dal lavoro sul corpo, sulla voce oppure dalla conoscenza?
“Non lavoro con loro sulla voce e non lavoro con loro sul corpo, tipologie di lavoro che conosco molto bene, avendo fatto l’Accademia, ma dove mi ritrovo meno. Lavoro molto sull’ascolto e sulla capacità comunicativa delle persone, quindi attraverso il dialogo avendo il coraggio di raccontare una storia. Coraggio significa avere cuore, è un termine che deriva dal latino. Quindi bisogna mettere il cuore nella narrazione, nel processo narrativo. Lavoro con le improvvisazioni, lavoro sulla restituzione di una narrazione, sulla restituzione di una storia, e poi si lavora – così come si sta facendo quest’anno per il tema ‘Stereotipi e pregiudizi’, in sinergia con tutta l’equipe, quindi con Cristiana, con Grazia e con Cinzia, sul cambio di soggettiva, sul riconoscere e riconoscersi, all’interno di un momento della storia, all’interno di un personaggio della storia e giocare con questo”.
In cinque anni di lavoro ad “Oltre i Banchi”, ci sono dei momenti che ti sono rimasti più impressi emotivamente per la storia raccontata e per come tu hai aiutato a far fuoriuscire la storia e metterla in scena?
“Di momenti così ce ne sono stati e continueranno ad essercene tanti, problematici o di un risultato felice. Mi ricordo di Ali, un ragazzo pakistano su cui poi Danila Muzzi ha fatto un corto documentario, aveva una gran voglia di raccontare la propria storia. Altri, invece, piano piano riescono a vincere la propria timidezza, come ad esempio Destiny oppure Hosseini quest’anno: entrambi sono ragazzi che rompendo gli indugi riescono a comunicare una maturità data da un’esperienza di vita che difficilmente si ritrova altrove, e lì si capisce quanto in realtà non siamo noi che conduciamo il laboratorio, ma quanto noi siamo in ascolto di esperienze e l’unica cosa che possiamo fare è cercare di valorizzare quelle esperienze lì, valorizzare questi ragazzi. Poi ci sono stati anche degli interventi di ragazzi italiani, universitari e non, che hanno agito. La cosa bella che vedo, che ho visto in passato e che continuo a vedere, è che anche per chi studia mediazione culturale, un conto è studiarla sui libri, un altro conto è scontrarsi con una realtà dove la fase esperienziale si rende viva e crea un modello vero e proprio, crea un’esperienza forte, uno shock forte su cui basare le proprie motivazioni per andare avanti nello studio, su cui basare le proprie motivazioni per capire cos’è fare mediazione culturale”.
Quanto tempo dedicate a questi ragazzi ogni settimana?
“Poco, molto poco, una volta a settimana per due, tre ore a incontro”.
Riuscite comunque a preparare uno spettacolo o incrementate le ore a ridosso della messa in scena?
“Sì, incrementiamo sempre le ore a ridosso dello spettacolo, come fa qualsiasi gruppo teatrale che, a dispetto di un lavoro di una volta a settimana, poi, nel momento in cui ci si ha come obiettivo quello di fare uno spettacolo, l’ultimo mese s’intensificano di più gli incontri e gli orari di prove. Però si parte con l’obiettivo non tanto di fare sempre lo spettacolo, ma di interagire e far interagire i ragazzi, perché se non si crea prima il gruppo, se non si crea prima una fiducia, un rapporto di fiducia tra noi e i ragazzi stessi, tra i ragazzi e loro stessi, non si crea un rapporto di tranquillità, serenità nel poter comunicare e diventa difficile questo tipo di laboratorio, e tanto più uno spettacolo e il confronto con il pubblico”.
Sottolinei il senso dell’ascolto, è qualcosa che tu avevi anche prima di quest’esperienza?
“Non lo so, forse l’ho sempre avuto o forse sicuramente è una parola chiave che risuona in questo contemporaneo. Grazie al lavoro di squadra, si allena l’ascolto e poi diventa una sorta di stella polare. Però non basta l’ascolto, serve anche la volontà di incidere all’interno di un gruppo, la volontà di incidere all’interno di un territorio attraverso il lavoro e, quindi, l’ascolto è la base, poi serve di più”.
Lo stesso tipo di lavoro lo fai anche alla Asl?
“Il lavoro è lo stesso, identico, ma cambiano le persone, quindi cambiano le criticità. Parliamo di un disturbo mentale, quindi il lavoro è molto, molto simile ma cambia il modo di approcciarsi. Sono tutte ragazze che vivono in situazioni a volte molte critiche; mentre, ad ‘Oltre i Banchi’ spesso i ragazzi che arrivano per rimanere in Italia, anche per un po’ di tempo per poi andare chissà dove, vengono dall’estero ed hanno vissuto il peggio: la modalità di lavoro è la stessa ma, cambiando loro, bisogna rendersi sempre un po’ nuovi. Rispetto all’obiettivo finale, così com’è stato per il laboratorio Oltre i Banchi l’anno scorso, questo lavoro nella Asl (da un anno a questa parte in Santa Maria della Pietà) è stato identico; invece, quest’anno a dicembre cercherò di mettere in scena un testo, non scritto da me, non scritto dai ragazzi, non lavorato durante il laboratorio, ma un testo di un autore che ha già scritto la drammaturgia, quindi una drammaturgia preesistente. Ancora devo decidere quale, ma lo vorrei fare cercando, tra le righe, di far raccontare qualcosa alle ragazze, questo perché ho imparato, e l’ho imparato proprio con i ragazzi di ‘Oltre i Banchi’, che prendere di petto quella che è la situazione, prendere di petto la problematica, spesso è poco funzionale all’obiettivo, spesso bisogna raggirare quello che è il problema perché tanto se il problema è evidente, se il problema è vivo, comunque emerge e, raggirando e parlando di qualcosa di altro (perché la vita è qualcosa che accade altro mentre stai facendo altro, non è il problema che vivi in quel momento lì), spesso si superano delle difficoltà, si capiscono meglio alcune dinamiche, si fa più esperienza perché viene alla luce, emerge quello che è un aspetto caratteriale: il carattere è la sommatoria di tantissime esperienze che uno ha avuto”.
Data la tua estrema sensibilità, come fai a non farti travolgere dalle storie raccontate?
“Inevitabilmente ogni tanto si è toccati emotivamente da ognuno di loro, soprattutto se poi ognuno di loro nel raccontare la propria storia, la propria esperienza, il proprio problema, la propria vita, ogni tanto si lascia andare a una comunicazione non verbale, a una comunicazione più emotiva, allora lì si ha molta difficoltà a non essere toccati emotivamente, e non dal punto di vista deontologico, ma perché l’obiettivo di un operatore culturale comunque deve essere molto forte: loro devono sentire che dall’altra parte hanno una persona che sa cosa fare e devono percepire che dall’altra parte c’è una persona, un operatore culturale che è lì per non annegare, non rimanere invischiato nella problematica, ma che possa offrire delle soluzioni, che possa offrire un confronto. Allora la scorza diventa più dura da scalfire e, poi, soprattutto quando si arriva a fine laboratorio e si ha come obiettivo quello di fare uno spettacolo, allora bisogna accelerare i ritmi e l’ascolto è sempre lo stesso ma la possibilità di essere toccati dal punto di vista emotivo viene meno, perché poi l’obiettivo è quello di toccare il pubblico emotivamente, non te. È un po’ come i dottori di fronte alle malattie: quando lo fai spesso, quando inizi ad operare un po’ tutti i giorni, un po’ ti costruisci quella scorza, un po’ ti rendi anche conto che non sei lì per dare una pacca sulle spalle o per piangere o per sorridere e basta. Questo lo puoi fare, anzi è doveroso, ma il tuo ruolo esige anche altro; quindi, non puoi permetterti di fare solo quello”.
I feedback di quando si va in scena sono sempre degli shock culturali positivi? Vedi partecipazione?
“Sì e no, questo però è un discorso molto ampio perché c’entra con quello che in questo momento si ha a disposizione cioè il supporto, i gruppi di ascolto, i gruppi di supporto attraverso il teatro, attraverso tutto quello che l’Occidente riesce a creare, l’Italia riesce a creare, ma c’entra anche con quello che serve e che manca terribilmente oggi: la valorizzazione di queste operazioni. Un pubblico che viene a vedere gli spettacoli del Teatro sociale non ha esperienza la maggior parte delle volte di Teatro sociale o di teatro, o ha troppa esperienza di familiari, di amici, di parenti, troppo esperienza umana e questo crea una spaccatura enorme. Spesso chi viene a vedere uno spettacolo di teatro ha voglia di vedere una performance e questo è possibile solamente se si ha un luogo teatrale dove la performance può essere agita in un certo modo, se si ha un lavoro per cui i ragazzi diventano realmente pian piano attori, ma, non essendo quello l’obiettivo, alcuni vedono lo spettacolo come deludente ma un’esperienza molto forte; altri vedono lo spettacolo con un occhio meno artistico e più interessato alle dinamiche che stanno alla base dello spettacolo e quindi ne escono sorpresi; altri invece si calano in una dimensione tutta nuova ed è il pubblico che preferisco. Questi vedono le storie, si sentono raccontare le storie e vivono le storie che gli vengono raccontate, non cercando dei personaggi, non cercando una regia, non cercando una scena, dei costumi e altro. Purtroppo, tutto questo oggi manca. Il Teatro sociale nasce con il Piccolo di Milano e nasce nel Dopoguerra per dare spazio a una sorta di categorie di persone che fino a quel momento lì non avevano avuto la voce ed era, quindi, di rottura rispetto agli intellettuali, rispetto al pubblico che impellicciato andava a vedere delle operazioni estremamente sofisticate. Quindi il Teatro sociale nasce per cercare di ricostruire un ponte con la società. Invece il Teatro terapia nasce nel 1970 ed è molto diverso. Il Teatro terapia è un po’ una cenerentola del teatro e non è teatro civile, che è un’altra cosa ancora. Essendo un po’ una Cenerentola, andrebbe costruito un pubblico, quindi servirebbe una casa, servirebbe un luogo dove poter riconoscere un certo tipo di metodologia, un certo tipo di teatro”.
Questa istanza a chi potrebbe essere presentata? È un lavoro che può essere fatto nelle scuole, sensibilizzando istituzioni locali e nazionali? Da dove si potrebbe partire?
“Il teatro si può fare e si deve fare ovunque, perché è un esercizio all’ascolto di sé e degli altri, perché è un esercizio umano, costante e doveroso che abbiamo nei confronti nostri e degli altri, quindi si può fare nelle scuole, si può fare nelle strade, ovunque. Laddove invece si incontrano delle criticità, s’incontra il Teatro sociale, e quello andrebbe fatto in un luogo protetto che possa essere un’aula o un teatro o una palestra o un seminterrato o un attico, poco importa, l’importante è che sia protetto per far sentire protette queste persone. Per rendere un luogo protetto, c’è bisogno di una politica, c’è bisogno di una équipe di studio, di lavoro, c’è bisogno di una Rete che si viene a creare tra associazioni, c’è bisogno di una sinergia, della volontà e della costanza di tante persone, di tante professionalità che hanno voglia di mettersi in gioco e che hanno voglia di supportare questo aspetto del teatro, quello legato al Teatro sociale. Quindi servirebbe tutto. Si potrebbe cominciare dal fare Rete, dal riconoscersi e riconoscere il valore di un certo modo di fare teatro”.